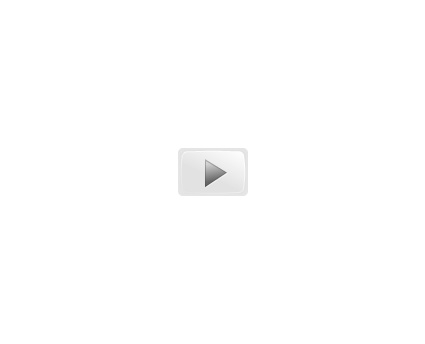Gilberto era il nonno
di Barbara, ma poteva tranquillamente essere anche il mio, tanto era il tempo
che io, che dalla morte del babbo mi son sempre sentita una senza famiglia, trascorrevo
a casa sua. C’erano famiglie che diventavano automaticamente la mia (seconda,
terza, quarta…), per osmosi. La sua era una di quelle. Così Gilberto, in fondo,
era un po’ anche mio nonno. Perfino se era talmente giovane da esser assai poco
credibile come nonno persino per Barbara, che sua nipote lo era per davvero ma
che invece lo chiamava papà.
Aveva occhi vivi e
scuri, braccia grandi, capelli folti e mani magiche. Credo che oggi lo definirebbero
un pranoterapeuta o roba così. Allora lo chiamavano semplicemente “il mago”. Il
suo vocione tradiva l’accento garfagnino della nascita dietro la cadenza
francese presa da sfollato oltre confine in tempo di guerra. Lui, per dire,
Barbara l’ha sempre chiamata Barbarà. Aveva
l’aria da burbero, e invece aveva un cuore grande così.
Quando non lavorava e gli
veniva a noia di stare in città, si esiliava volontariamente a Vecoli, dove possedeva
un largo appezzamento di terreno coltivato a orto con ogni ben di dio e un
prefabbricato che per lui – e per tutti coloro che gravitavano attorno alla sua
orbita – era una sorta di residenza estiva, un po’ quel che Schönbrunn doveva
aver rappresentato per gli Asburgo quando fuggivano dalle mura del Hofburg.
Gilberto vangava,
arava, seminava, zappava senza sosta e la Beppina, la su’ moglie, cucinava, discorreva, s’arrabattava e badava a
mettere in dispensa o in congelatore i frutti del raccolto.
Io, che provenivo da
una città ancor più città di quanto non fosse Lucca, avevo viaggiato per laghi,
per mari e per monti, ma la campagna, quella vera, proprio non l’avevo vista mai.
Le pesche per me avevano ragion d’essere soltanto dentro alle cassette di legno
dell’ortolano, le fave manco sapevo che esistessero e i piselli potevano esser
solo in scatola e Cirio. Forse – ma non posso dirlo con assoluta certezza –
studiando Darwin mi si era instillato il dubbio che *prima* di finire in
scatola potessero magari avere un altro aspetto, tuttavia non credevo
differissero di molto da ciò a cui ero abituata. Ad ogni buon conto, so per
certo di aver scoperto l’esistenza dei baccelli soltanto a Vecoli.
Ricordo un’atmosfera
calda e gioviale, vino ne’ fiaschi, la
Beppina che trafficava in su e in giù (non sta mai ferma quella donna, manco
ora che ha ottant’anni!), la sua amica Palmira che friggeva frati nemmeno
dovesse sfamare un reggimento ( e tutti, attorno, a cercare di carpirle
la ricetta che lei si tenne sempre bella stretta e segreta), e ricordo risa, chiacchiere
e fave gnude e pecorino fresco e
olive piccole, in salamoia. E l’olio novo.
E i piselli. Ciotole colme di piselli sgranati, grossi e sodi e di un bel verde
brillante. La nuance verde pisello fu per me, in effetti, un’altra scoperta,
abituata com’ero al verde stantio di quelli in scatola. Ma ciò che mi lasciò più
basita, dopo che la Beppina li ebbe cucinati, furono la consistenza ed il
sapore. Nulla a che vedere col molliccio e col retrogusto da brodo di lattuga zuccheroso
e dolciastro dei Cirio, ovviamente. Dev’esser stato allora, quella prima volta
che ho mangiato i piselli davvero, che ho imparato che può esister la dolcezza
anche se non c’è zucchero. Un po' come in amore.
Da allora, ogni volta che posso, quand’è stagione,
compro piselli freschi. E, ogni volta, mentre li sgrano, ripenso a Gilberto, ai suoi occhi
neri, alle sue mani forti e al suo cuore grande. |
| © singlemamafranny - all rights reserved |
questo (non) racconto partecipa all'EDS ipogeusia de La Donna Camèl insieme a